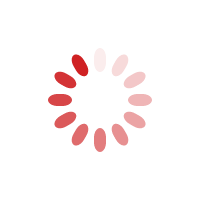Il dato è mio, ma non lo gestisco io
Diamo tanta confidenza al web, senza chiederci se possiamo fidarci. La Rete, come tutto quello con cui abbiamo a che fare, dobbiamo conoscerla: avremo solo vantaggi e niente problemi. E non ci faremo male.
Si apre la pagina web, compare l’informativa sulla privacy: quanti di noi cliccano ‘scopri di più? Macché, tutti, o quasi, andiamo frettolosamente su ‘accetta’ e continuiamo a navigare. Così facendo, in pratica diamo l‘ok a come quel sito gestirà quanto viene a sapere di noi. Bene. Anzi, non tanto. Ogni volta che prendiamo sottogamba questa obbligatoria informativa, o non ce la filiamo proprio, in realtà autorizziamo vari soggetti, diversi dal titolare della pagina che stiamo navigando, a trattare i nostri dati. E, a dire la verità, anche ce si prendessimo la briga di andare a scoprire di più, in molti casi ci troveremmo di fronte a una serie di informazioni difficili da capire, e a un elenco più o meno sconfinato di ‘soggetti diversi’ che condivideranno i nostri dati: un labirinto. Chi ci capisce qualcosa? Sia chiaro, la maggior parte delle imprese, rispetta le attuali norme sulla privacy e utilizza i dati principalmente per migliorare la sua offerta, di per sé non è un male. Ma un rischio in questo nuovo mondo digitale esiste. Proviamo a capirci qualcosa con l’aiuto di un esperto.
Di quali dati stiamo parlando
Che ce ne rendiamo conto o no, tutto quello che facciamo online diventa un dato: i riferimenti anagrafici che volontariamente inseriamo per accedere a un servizio, i gusti, le tendenze, le opinioni che esprimiamo navigando sul web, interagendo sui social. La tecnologia è in grado di raccogliere, organizzare, elaborare e conservare ogni ‘virgola’ digitale che produciamo. Siamo noi a generare il “petrolio” del terzo millennio: i famosi Big Data. “Non proprio”, ci corregge Andrea Lamperti, direttore dell’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano.
Cosa sono i Big Data
“I Big Data - spiega Lamperti - sono un concetto ancora più ampio. Si tratta di insiemi di dati, che possono essere strutturati o destrutturati. Dati strutturati, ad esempio, sono tutti i link, le pagine che un utente naviga all’interno di un sito, o la temperatura di ogni giorno per ogni ora. Mentre le immagini, o gli insight (commenti e reazioni, ndr) sono dati destrutturati, che però rielaborati possono dare delle informazioni alle aziende”. Oggi ci sono tecnologie in grado di gestire e mettere in relazione smisurati insiemi di dati: è una nuova disciplina, la big data analitycs. Si tratta di processi e operazioni impensabili prima di questa era tecnologica, non c’erano sistemi sufficientemente potenti, e men che meno si potevano fare a mente. Bene, anzi, un momento: ma di chi sono tutte queste informazioni, e che ci si può fare con i Big Data, compresi i nostri?
Il business delle informazioni
Con i Big Data si possono fare tante cose, anche molto utili, e si fanno gli affari: la chiamano Data Economy. Pensiamoci bene: noi stessi cediamo le nostre informazioni per poter navigare e usare, per esempio, Google. Sono servizi che crediamo di usare gratis, in realtà “paghiamo” con le informazioni che lasciamo navigandoci. E cosa ci fanno con i nostri dati? “Le spiego - ci soccorre sempre Lamperti -: in Internet le aziende raccolgono dati attraverso una serie di attività più o meno esplicite riguardo alla navigazione degli utenti. Questa raccolta, tramite elaborazioni, permette alle aziende di ottimizzare la propria offerta e la propria comunicazione”. Sarà capitato a tutti: dopo aver cercato qualcosa online, ci ritroviamo sul display - senza averlo chiesto - oggetti e offerte correlate alla nostra ricerca. E no che non è un caso. “In qualche modo - continua l’esperto - quel sito ci ha clusterizzato, ci ha classificato come interessati a quell’oggetto e va a comprare lo spazio pubblicitario presente in altri siti in base ai dati che noi con la nostra navigazione abbiamo fornito”. Anche i social network sono una miniera d’oro. Per avere un’idea della questione, ecco qualche informazione trovata sul più importante network italiano dedicato alla trasformazione digitale: “Facebook, con il suo miliardo di iscritti, sa persino quando una storia d’amore è arrivata a un punto critico. Sulla base degli aggiornamenti di stato delle bacheche (ogni minuto sono pubblicati 3,3 milioni di post), l’azienda può prevedere se un rapporto è destinato a durare, con una precisione inquietante. Per non parlare di Twitter che ogni 60 secondi movimenta 347mila tweet e che, come le altre Big Tech, ha sviluppato una API (Application Program Interface) che consente a terze parti di accedere a ognuno di questi (per definizione tutti pubblici): si tratta di dati non strutturati, scandagliati da nuove tecniche di sentiment analysis che riescono a capire le emozioni contenute nelle informazioni testuali, aiutando i decisori (aziendali e politici) a capire dove va il vento dell’opinione pubblica” (fonte: Networkdigital360).
Garanzia del diritto alla privacy: quale diritto?
Il diritto alla nostra riservatezza, o privacy, su chi siamo e cosa ci piace, oggi è come una coperta corta. Nel mondo di Internet formalmente viene rispettato, ma in pratica viene in qualche modo disatteso. O meglio, cambia forse il concetto: quello che nel mondo reale è diritto alla privacy, online si trasforma in diritto di proprietà, e dunque anche di sfruttamento, e su questo forse una normativa precisa ancora non c’è. Difficile per noi comuni utenti averne consapevolezza, il concetto riguarda dinamiche e tecnologie virtuali che mediamente non conosciamo, se non per la navigazione che facciamo. “Anche se in questo ambito la normativa sta evolvendo - ci spiega l’esperto del Politecnico - e ci sono soluzioni tecnologiche che cercano di avvicinare la gestione del dato alla singola persona, che rimane nel pieno controllo dei suoi dati digitali e può decidere di cedere all’azienda quello che vuole. In realtà, il web è un ambito completamente nuovo, non legato a qualcosa di tangibile, quindi non è applicabile quello che succede normalmente in un mercato che scambia fisicamente beni e servizi”.
Dobbiamo essere più consapevoli
In futuro, forse, potremmo ‘mettere’ in un luogo virtuale le nostre informazioni, potendo poi decidere - di nostra volontà - di condividerle con le aziende che lo richiedono, magari in cambio di un servizio che ci interessa; se avverrà, sarà certo un’altra rivoluzione del web. “Abbastanza radicale - concorda Lamperti -. Ciò non significa che i servizi attuali non potranno continuare ad esistere, sarà da stabilire su che informazioni si baseranno”. Insomma, il progresso tecnologico potrebbe indurci a essere utenti più responsabili, attenti e consapevoli. Attualmente non percepiamo un pericolo legato alla perdita di controllo delle nostre informazioni. “Ci sono esperti e guru internazionali - precisa - che mettono in guardia sul fatto che i grandi player stiano sfruttando tutte queste informazioni prodotte dai consumatori per migliorare il proprio business e fare più soldi. In realtà il singolo utente non percepisce un dolo nei suoi confronti, il fatto non gli crea dei danni o un impoverimento”. Anche perché, diciamolo, il web è davvero una gran comodità.
Il rischio
Un problema però esiste. Al momento non c’è una garanzia sufficiente che questi dati immagazzinati dai grandi player non possano essere usati per competere, anche da altri soggetti, in ambiti diversi da quello dei consumi: la politica, la finanza, l’ecologia, questioni morali, religiose, sociali. Questo è il punto: un tema etico tanto nuovo quanto grande. Sembra ormai provato che negli ultimi anni siano state utilizzate fake news (notizie false) costruite apposta (sulla base di dati digitali) per indirizzare - o condizionare - l’opinione pubblica su temi come le elezioni politiche o la Brexit. Di questo rischio, o pericolo, noi consumatori iniziamo a percepire qualcosa. “Qui si apre un altro tema - precisa Lamperti - cioè che la tecnologia, la conoscenza, le competenze e gli investimenti di questi grandi player internazionali sono sempre più consistenti e più avanti rispetto a quelli che le normative dei diversi paesi, o dell’Europa, possono mettere a disposizione”. Insomma esistono aree grigie che i regolamenti dei governi non hanno ancora messo a fuoco, per non dire che ancora non hanno capito, o di cui neppure conoscono l’esistenza. Il dubbio aumenta, insomma: il mondo digitale è davvero pericoloso? Chi meglio del nostro esperto ci può illuminare.
Il web è malvagio?
Il web è un mondo che conosciamo poco ed è poco regolamentato. Ma si può considerare malvagio? “No, non è malvagio - spiega Lamperti -, almeno per due motivi: il primo è la scarsa conoscenza: tutto ciò che non si conosce è percepito come oscuro, pericoloso, ambiguo, minaccioso più di quanto possa essere. E poi è indubbio che quando sono arrivati i grandi player, inizialmente sono mancati controlli e valutazioni nel concedere libertà e prerogative che oggi li hanno portati ad assumere il peso che hanno. Forse non si immaginava che sarebbero diventati così grandi”. Dal suo Osservatorio Lamperti ce ne dà una dimensione: “Questi grandi player (Google, Amazon, eccetera) ad oggi raccolgono quasi l’80% della pubblicità digitale in Italia: è chiaramente un stato molto particolare del mercato, significa che tutta la pubblicità online è gestita da 4 o 5 operatori, rispetto a a una pletora che si gestisce il restante 20%. E in più queste aziende dichiarano il fatturato non tutto in Italia. Per una logica di server e di contrattazioni digitali, i ricavi vengono imputati ad altri Paesi e l’imposizione fiscale italiana in qualche modo viene elusa”.
Il business della sicurezza
La questione è complicata, si consuma in uno scenario senza confini, mica per niente si chiama World, Wide Web (rete di dimensioni mondiali). In questa prateria, cosa possiamo fare noi utenti? Magari cominciare a essere più consapevoli, a fare pressione per essere informati su come e da chi vengono usate le informazioni che produciamo, sapere che se ci offrono un servizio gratis, proprio gratis in realtà non è, come abbiamo visto: in cambio cediamo informazioni. Se aumenta la percezione di un pericolo del digitale, essere rassicurati sarà un bisogno sempre più sentito dagli utenti. E infatti tecnologie più garantiste esistono già. Come la piattaforma Solid, piuttosto nota perché è stata progettata dallo stesso ‘papà’ del web, Tim Berners Lee, fra i primi a lanciare allarmi sui pericoli di un uso improprio della sua creatura. Il nostro esperto dice che cresce da parte dei gestori dei dati la consapevolezza di dover cambiare direzione andando verso una gestione monitorata, permettendo all’utente finale piuttosto che alla filiera il controllo delle proprie informazioni. Succederà? Dipende. Secondo Lamperti può arrivare una tecnologia talmente dirompente (come è successo con lo smartphone, ad esempio) che si impone sul mercato e il consumatore si adegua; oppure può essere una forte pressione esercitata dagli utenti in quella direzione, che taglia fuori dal mercato chi non si adegua. Oppure, ancora, diventa uno standard tecnologico che gli utenti adottano senza accorgersene. Certo, un’adeguata normativa aiuterebbe.
Galleria fotografica
Condividi questa pagina :